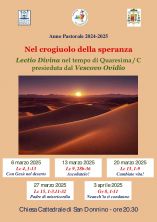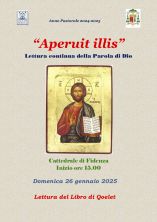Qual è l’origine del Mercoledì delle Ceneri?
La storia della liturgia ci documenta che il Mercoledì delle Ceneri, quale giorno inaugurale del cammino quaresimale verso la Pasqua del Signore, entra nella prassi ecclesiale per tutti i fedeli solamente verso la fine del I millennio (IX secolo circa). Nella Chiesa antica è già attestato un rito che prevede la vestizione di un abito di penitenza e l’imposizione delle ceneri sul capo dei fedeli maschi (per le donne era contemplato un segno di croce sulla fronte con la cenere) quale segno penitenziale che caratterizza un percorso di conversione in vista della loro riconciliazione e riammissione alla comunione con la Chiesa il giorno del Giovedì santo. Le testimonianze di Cipriano vescovo di Cartagine e del presbitero Tertulliano (III secolo), per quanto riguarda la Chiesa del nord Africa, vanno in questa direzione. Gesù stesso, in continuità con la tradizione profetica dell’Antico Testamento, rimanda a questa prassi in Mt 11,21: “Se a Tiro e Sidone fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza avvolte nel cilicio e nella cenere”. A partire dall’VIII-IX secolo nelle Gallie e dall’XI secolo a Roma è attestato il rito di imposizione delle ceneri sul capo di tutti i fedeli (e non solo dei penitenti) mediante una formula di benedizione propria, quale inizio del cammino quaresimale orientato verso la Pasqua del Signore. La prescrizione successiva di ottenere le ceneri dai rami di ulivo dell’anno precedente bruciati risale al XII secolo.
Qual è il carattere proprio dell’inizio del cammino quaresimale?
A questo proposito è bene ricordare quanto la Costituzione sulla Liturgia del Concilio Vaticano II (Sacrosanctum concilium 109) precisa in riferimento al carattere proprio della Quaresima: “Il duplice carattere della Quaresima che, soprattutto mediante il ricordo o la preparazione al Battesimo e mediante la penitenza dispone i fedeli alla celebrazione del mistero pasquale con l’ascolto più frequente della parola di Dio e la preghiera più intensa, sia posto in maggiore evidenza tanto nella liturgia, quanto nella catechesi liturgica”. Pertanto, memoria del battesimo e dimensione penitenziale caratterizzano l’inizio del cammino quaresimale, che nel Mercoledì delle Ceneri trovano una sintesi eloquente.
Qual è il significato del simbolo delle Ceneri?
Va precisato che le Ceneri sono un sacramentale ovvero un segno che rimanda ad una dimensione spirituale più profonda; esso trova nel cammino di conversione, fatto con fede e senza ipocrisia, la sua significazione più autentica. Il segno delle Ceneri è solo gesto che indica un percorso più ampio e che necessita di essere accompagnato da atteggiamenti di autenticità davanti a Dio: atto di affidamento alla sua misericordia, verità con se stessi, sguardo di speranza sulla propria vita, atteggiamenti di compassione e di prossimità nei confronti della storia umana in cui si abita, astensione dalla pretesa di giudizi sprezzanti su di sé e sugli altri, denuncia di ogni forma di idolatria e di seduzione che la mondanità produce, umile ricerca del senso della vita ricominciando da Dio.
Qual è il vero volto del digiuno?
Il vero volto del digiuno è precisato con sapienza nella Scrittura; è unito alla preghiera e all'elemosina costituendo uno degli atti essenziali che esprimono davanti a Dio l'umiltà, la speranza e l'amore del credente. Il digiuno, nella rivelazione, non è conquista ascetica che procura uno stato di esaltazione psicologica o religiosa, ma un atteggiamento esterno che esprime dipendenza e di umiltà per accogliere l'azione di Dio e mettersi alla sua presenza. La Scrittura, in particolare, offre tre modelli di esperienza di digiuno che precedono un incontro significativo con Dio. Essi tracciano un itinerario pedagogico nella fede e aiutano a cogliere da un lato, il senso profondo della provvisorietà e, dall'altro, la disponibilità più vera per una relazione che arricchisce la vita di una presenza. Mosè rimane quaranta giorni e quaranta notti sul Sinai senza mangiare pane e senza bere acqua, mentre alla scuola di YHWH scrive le parole dell'alleanza. Elia percorre un cammino di quaranta giorni e quaranta notti fino all'Horeb, digiunando, perché già saziato dal pane e dall'acqua con i quali Dio provvidente l'aveva nutrito; al termine discerne la sua presenza nel silenzio profondo e nella solitudine. Gesù stesso inaugura la sua missione di annuncio del regno di Dio con un atto di abbandono fiducioso al Padre, digiunando quaranta giorni nel deserto. È ancora Gesù a mettere in guardia, collocandosi in una linea di continuità con la tradizione profetica, da alcuni pericoli celati da una pratica distorta del digiuno: formalismo, orgoglio e ostentazione di sé per essere visti dagli uomini, distanza tra una prassi penitenziale e la quotidianità dell'esistenza. Per essere gradito a Dio, il digiunare del credente deve procedere in stretto parallelo con l'attenzione ai fratelli e con una ricerca della vera giustizia. Gesù, pertanto, invita a digiunare con una discrezione e una saggezza note solo a Dio che vede anche nel segreto. Solo questo atteggiamento aprirà il cuore del discepolo ad una esigenza di giustizia interiore che invoca costantemente: «O Dio, abbi pietà di me peccatore!» (Lc 18,13). Quale digiuno viene, allora, prospettato? Dalla Scrittura emergono alcune caratteristiche: il vero digiuno conduce a cogliere la dinamicità del provvisorio, è fatto in segreto e davanti a Dio, è unito alla preghiera e all'elemosina, è, infine, un digiunare per amore di Dio. Il digiunare è apertura a discernere il dono da condividere assumendo la connotazione di speranza e di lode. Il digiuno autentico è quello vissuto nell'attesa del ritorno dello sposo perché al suo arrivo si faccia festa. Il digiuno pone nella condizione di sobrietà e di vigilanza perché non ci si addormenti nella crapula, nel torpore dell'indifferenza e del nichilismo. In tal senso il digiuno diventa esperienza di comunione con Cristo, rifuggendo da ogni forma di neopelagianesimo, verso l'esodo pasquale in una dinamica di conversione. L'atteggiamento esterno del digiuno trova la sua valenza se colto in una prospettiva di apertura all'azione di Dio che si manifesta come Signore dell'esistenza.
Da che cosa astenersi?
Ritengo che, a questo proposito, sia necessario compiere un passo in avanti ovvero il superamento di un formalismo esteriore che limita la prassi del digiuno solo ad astenersi da alcuni alimenti. Nel contesto odierno, a mio parere, è necessario ribadire con Gesù che “non è ciò che entra nell’uomo a contaminarlo, ma ciò che esce dal suo cuore; questo sì contamina l’uomo” (cfr. Mc 7,14-15.20). Al contrario, è necessario lavorare per la giustizia, per la pace, per la salvaguardia del creato, per il rispetto della dignità di ogni persona, lottando contro ogni forma di complicità con il male; tutto ciò scaturisce dalle esigenze proprie dell’evangelo.
Digiuno, preghiera, carità fraterna
Il digiuno autentico, il cui significato abbiamo poco prima tracciato, è sempre unito alla preghiera e alla carità fraterna (elemosina), come del resto è indicato nel testo evangelico di Mt 6,1-6.16-18 e previsto per il Mercoledì delle Ceneri (senza disattendere gli altri testi biblici del giorno: Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2). Un cammino spirituale che trova nell'itinerario penitenziale una sua espressione tipica non può rinchiudersi in un particolarismo consolatorio, ma deve aprirsi al superamento della propria grettezza e della propria autosufficienza. Tale apertura si concretizza in un atteggiamento di dono e di amore che si esprime propriamente come comunione fraterna e condivisione. Ciò che nell'arroganza appare riduttivo di sé, nell'amore diventa apertura alla storia; ciò che è descritto come attaccamento di sé, si converte in una condivisione attraverso un movimento che conduce ad un cambiamento radicale: da peccatori a discepoli della compassione del Signore. La condizione dell'uomo, quando è caratterizzata da un confidare in sé stesso, si tramuta ben presto in isolamento che produce una chiusura tesa a difendere qualcosa che, in realtà, sarà perso in modo irreparabile. La prassi quaresimale, pertanto, si offre al credente come momento critico in cui viene svelata la tracotanza del peccatore e la necessità di uscire dalla propria paralisi. La conseguenza esistenziale, poi, si fa più attenta al frutto penitenziale del cammino ponendo attenzione all'atteggiamento di chi passa dalla autosufficienza al dono. Il digiuno, dunque, conduce i credenti, oltre ogni retorica, ad essere testimonianza di carità per un servizio ai fratelli.
Qual è il significato delle formule per l’imposizione delle Ceneri?
Rispetto al Missale Romanum (1570) scaturito dalla riforma liturgica del Concilio di Trento, il Messale Romano riformato da Papa Paolo VI dopo la benedizione delle Ceneri contempla due formule per la loro imposizione sul capo dei fedeli; ambedue le formule sono radicate nella Scrittura senza equivoci. La prima formula: “Convertitevi e credete nel Vangelo” (cfr. Mc 1,15; Mt 3,2; 8,10); la seconda: Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai” (cfr. Gen 3,19; 18,27; Sal 103,14; Qo 3,20; Sap 11,22; Sir 33,10). L’atto di imporre sul capo dei fedeli un poco di cenere porta con sé il senso di una missione, un compito che viene affidato e che il fedele accoglie con umiltà e responsabilità. La significazione dell’atto stesso è precisata ulteriormente proprio dalle due formule bibliche ricordate e che il ministro pronuncia ad alta voce davanti al credente che accoglie l’austero simbolo delle Ceneri. Potremmo riassumere in questi tratti il senso profondo di tutto ciò. In primo luogo, si fa memoria ai credenti che la condizione di discepoli sempre in cammino li caratterizza in ogni istante della vita. Siamo sempre dei viatores, pellegrini di speranza che tengono fisso lo sguardo su Gesù, Evangelo di Dio, buona notizia per l’umanità, fondamento della fede dei credenti. In secondo luogo, è ribadito che il discepolo non è seguace di una ideologia o di una nuova morale che insegna l’arte del vivere nella complessità della storia odierna; al contrario il discepolo sta dietro al maestro unico che è Gesù, Parola eterna del Padre. Infine, la condizione che caratterizza l’umanità è il limite, la finitudine di tutto ciò che è terreno, la temporalità; tutto ciò, se da un lato fa memoria a noi della nostra fragilità che non possiamo rimuovere, dall’altro ciò potrebbe condurre ad assumere uno stato di rassegnazione passiva irreparabile e senza speranza. Al contrario, l’evocazione della condizione mortale se fatta davanti a Dio e confidando nella potenza dell’Evangelo, diventa profezia di risurrezione e di vita eterna alla quale ogni discepolo di Gesù il Cristo è chiamato. In tal senso i due richiami contenuti nelle formule costituiscono un esplicito rimando al mistero della Pasqua del Signore, verso la quale il credente cammina nella speranza.
Quale rapporto tra il Mercoledì delle Ceneri e il cammino quaresimale?
Sul versante storico liturgico al riguardo si può ritenere che la fissazione del giorno di mercoledì è legata al fatto di poter stabilire un periodo di quaranta giorni (con tutta la ricchezza simbolica che a questo numero viene attribuita nella Scrittura) che precedono la Pasqua del Signore. Più precisamente, si calcolano quaranta giorni effettivi dal mercoledì delle Ceneri al mercoledì della Settimana santa, escludendo le domeniche, per lasciar posto al Triduo pasquale che contempla il suo inizio nella celebrazione del Giovedì santo in Coena Domini.
+ Ovidio Vezzoli
Vescovo di Fidenza